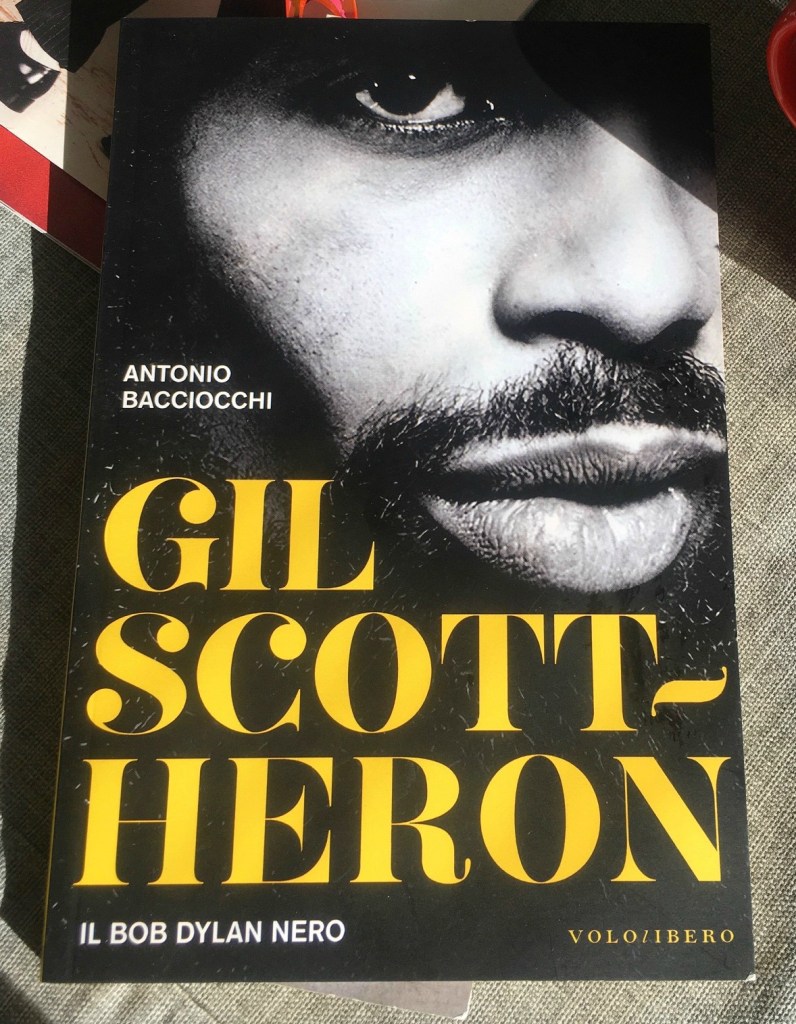Episodio 5

Questa canzone comincia come una storia per bambini:
C’era una volta gatta che aveva una macchia nera sul muso. L’effetto visivo è immediato, immaginiamo subito quel muso, cioè quel naso colorato di nero.
C’era una volta una gatta
che aveva una macchia nera sul muso
e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu
Il testo della canzone è autobiografico, cioè racconta un episodio della vita del suo autore Gino Paoli. Siamo nella casa di Gino a Genova, la sua città di origine, precisamente nel borgo marinaro Boccadasse dove abitava con sua moglie e la gatta di nome Ciacola. Gino parla di una soffitta, cioè una casetta all’ultimo piano, sotto il tetto, quel tipo di casa poco confortevole dove abiti quando sei un giovane artista all’inizio della carriera e senza soldi in tasca…
Se la chitarra suonavo
La gatta faceva le fusa
Ed una stellina scendeva vicina, vicina Poi mi sorrideva e se ne tornava su
Gino suonava la chitarra e la gatta era contenta, faceva le fusa, cioè quel suono che fanno i gatti quando sono felici, tipo prrrrrr. La situazione era semplice ma tanto magica che una piccola stella scendeva dal cielo per un momento.
Poi lo scenario cambia bruscamente, Gino va ad abitare in un altro quartiere e cambia casa:
Ora non abito più là,
tutto è cambiato, non abito più là, ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu…
Però, la nuova casa bellissima non è sufficiente per essere felici. Gino continua a pensare alla soffitta vicino al mare e alla gatta con una macchia nera sul muso.
Ma, io ripenso a una gatta
che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina, che ora non vedo più…
Tag
Livello A1/A2, tempo imperfetto, gatti, Genova
Nota biografica
Gino Paoli è uno dei cantautori più famosi della generazione che ha esordito negli anni 60 e fa parte della scuola genovese insieme a Bruno Lauzi, Luigi Tenco. Nelle sue canzoni parla di intimità e d’amore in maniera non convenzionale e si occupa poco di politica, come al contrario aveva fatto Fabrizio de André per esempio, il più giovane del gruppo dei genovesi. Gino ha avuto una vita molto tormentata, piena di successi ma anche di momenti di grande dolore personale che l’hanno portato a prendere delle pause dalla scena musicale.